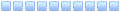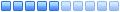Messaggio
da NicolaSeverino » gio mag 03, 2018 8:05 am
Per quanto riguarda le citazioni e le possibili ipotesi sul decempedalis, devo dire che il quadro non è affatto esauriente e piuttosto confuso. Si gioca sull'interpretazione delle parole e del senso delle frasi riportate dagli antichi scrittori. Poi non sappiamo se i Copisti del medioevo hanno aggiunto del loro o storpiato parte dei termini originali. Per quello che posso dire, l'interpretazione delle parole e delle frasi può portare solo ad una delle seguenti probabili ipotesi:
1) Lo Stoicheion si riferisce al sistema di misurazione della lunghezza dell'ombra proiettata dal proprio corpo con il campione di misura del "piede";
2) Lo Stoicheion è propriamente uno strumento, orologio solare, formato da un'asta campione (altezza standard) e la lunghezza della sua ombra durante le ore del giorno è misurata nell'unità del "piede".
3) Lo Stoicheion potrebbe identificarsi con la tavola del "Pedes Horarum" in cui viene riportata la corrispondenza della lunghezza dell'ombra dell'uomo, di una colonnetta o di una statua con altezza "campione", nelle singole ore per ciascun mese.
Se dobbiamo stare ai commentari, alle interpretazioni e traduzioni degli autori del XVII e XVIII secolo, come Causabon, Salmasio, Petavio, ecc., i quali lavoravano certamente sui codici manoscritti redatti dai Copisti del Medioevo, allora bisogna convenire che la scoperta maggiore spetta a
Salmasio, nel 1600 il quale riporta una epistola in greco la cui traduzione inequivocabilmente dimostra che lo Stoicheion e il Decempedalis non è altro che il metodo di misurare le ore computando la lunghezza dell'ombra del proprio corpo durante la giornata, nell'unità di misura del "piede".
L'unica dissertazione che sono riuscito a trovare in lingua italiana su questo argomento è quella pubblicata nell'opera "Le Pitture Antiche di Ercolano", tomo terzo, Napoli 1762. Qui voglio riportare solo le parti in italiano che riassumono la maggior parte delle citazioni relative allo stoicheion e al decempedalis.
Menandro, presso Ateneo VI.10.p. 143 riporta l'invito ad una cena di "dodici piedi" del parassita Cherofonte. Esichio, avendo presente lo stesso luogo di Menandro scrive: di dodici piedi. Così dicono sottintendendo "stoicheion" o "scias", poichè così convenivano di andar alla cena, quando la linea (o l'ombra) era di dodici piedi; Polluce generalmente dice: dall'ombra conosceano il tempo di andar alla cena, la quale ombra chiamavano anche "stoicheion"; e lo Scoliaste di Aristofane (Ecclesiazuse) spiegando le parole "decapon" e "stoicheion", di cui si serve il Comico per dinotar l'ora della cena, dice: l'ombra del Sole quando sia di dieci piedi vuol dunque dire ch'è tardi...(...)... Esichio ancora riporta l'ombra di sette piedi...(...)...
Ma, come dicevo prima, la citazione più significativa è data da Claudio Salmasio che nelle sue Esercitazioni Pliniane del XVII secolo, riporta un passo greco dell'Epistola di Teodoro a Teofilo, la cui traduzione data dagli autori delle Pitture Antiche d'Ercolano recita:
Bisogna dunque, che per dinotar le ore , tu misuri l'ombra tua co' tuoi piedi , mettendo un piede dopo l'altro, sino al luogo, in cui giunge l'estremità della tua testa mostrata dall'ombra tua, stando diritto.
Da qui nasce l'horihomo, parola coniata probabilmente durante la Rinascenza che ancora si trova raramente in qualche antico testo. Qui sotto si possono vedere due immagini dell'Horihomo. Quella a sinistra, del XVIII secolo, è tratta da G. Paltrinieri, Meridiane e orologi solari di Bologna e Provincia, ed. Artiere, Bologna 1995; quella a destra da La Meridiana di Torino di Sandro Doglio e Mario Tebenghi, Ed. Daumerie, 1989. Si tratta probabilmente di uno schizzo dello stesso Tebenghi, famoso meridianista piemontese.
Interessante è anche la conclusione di Salmasio, con cui si può essere tranquillamente d'accordo, tradotta e riportata dai nostri autori delle Pitture Antiche d'Ercolano:
Quindi Salmasio deduce, che gli antichi prima dell'invenzione degli Orologii per conoscere non già esattamente le ore, ma all'ingrosso, quanto il Sole si era avanzato verso Mezzogiorno, o declinato verso Occidente, usavano di misurar l'ombra del proprio corpo ciascuno co' proprii piedi, e che così si han da spiegare gli antichi autori greci, che disegnano il tempo co' piedi d'ombra: che questa maniera si fosse ritenuta, anche dopo trovato l'Orologio, da' rustici: e che potea anche ridursi alle regole della
Gnomonica con supporre uno gnomone uguale alla statura dell'uomo; potendosi in tal maniera spiegar anche le ombre date da Palladio per ciascun mese....
Ma i conti non tornano perchè Scaligero spiega a Manilio la cena di dodici piedi di Menandro che doveva farsi nell'ora duodecima, quando cioè l'ombra è alla linea duodecima da cui si dovrebbe dedurre che a "undici piedi" corrisponda l'ora undecima, a "dieci piedi" corrisponda l'ora decima ecc, mentre ciò è assurdo. A complicare le cose ci si mette Polluce che spiega alcuni passi degli Scoliasti e dei Grammatici antichi i quali usavano un termine greco per riferirsi alla mezza ora:
L'ora e la mezza ora era detta dagli antichi semeion , come usa Menandro; e dall'ombra si dinotava, cosi', l'ombra di dieci piedi, o di undici piedi.
Con l'introduzione di questo termine, semeion, per indicare la mezzora, si può spiegare finalmente il fatto che Ebulo, presso Ateneo, nomina per la cena l'ombra di venti piedi da intendersi espressa in "mezzore" e quindi equivalente alla cena di dieci piedi di Menandro.